L’obiettività della Storia quale fondamento del sapere, cruciale in un’epoca di rinnovata ignoranza
In Italia l’attuale scenario sociale propone delle situazioni allarmanti per quanto riguarda le conoscenze dei giovanissimi – specie dei ragazzi fra i 14 e i 19 anni – in merito alla storia.
Non si tratta solo di casi riscontrabili nelle scuole – in cui troppo spesso gli insegnanti non sono in grado di affrontare le varie epoche in modo critico, spiegando le cause che hanno condotto a determinati fatti – ma dell’idea (ormai diffusa soprattutto sui social e dai social) di raccontare la storia in un modo del tutto personale, prescindendo da un valido e opportuno metodo di studio.
Quest’ultima tendenza rischia di divenire una vera e propria piaga in primis a livello educativo, dal momento che la nostra epoca non incoraggia certamente la volontà di approfondire un evento o la biografia di un personaggio storico, anzi: sui media sembra che la credibilità di certe pagine del passato dipenda dal volume del tono di voce con cui le si urla, in una prospettiva distorta che fagocita e sostiene ogni genere di arrogante ignoranza.
Per non strumentalizzare la storia, uno dei principali fondamenti nell’insegnarla dovrebbe essere la necessità di mantenersi il più possibile obiettivi su ciò che si spiega, al di là di quelle che possono essere le proprie tendenze politiche personali.
È indubbio, infatti, che qualsiasi insegnante dotato di buon senso sappia quanto il suo ruolo possa essere rilevante specie nello studio della storia contemporanea – ossia dell’arco di tempo dal 1789 ai giorni nostri – imprescindibile per la comprensione di aspetti cruciali nell’evoluzione mondiale dell’essere umano.
Dunque i docenti dovrebbero possedere un’onestà intellettuale così elevata da permettere loro di scegliere innanzitutto degli ottimi manuali scolastici, ossia dei libri capaci di narrare gli eventi storici – anche i più drammatici e vergognosi – senza l’ombra del condizionamento ideologico.
Chiaramente non si tratta di un’impresa semplice, ma è fondamentale che i giovani abbiano modo di conoscere tutti i dettagli relativi a ogni avvenimento, che si tratti del nazifascismo così come del comunismo.
A tal riguardo è certo che molti libri di storia schierati a sinistra – cosa più volte denunciata dai partiti di destra durante gli anni scorsi – abbiano omesso per anni delle argomentazioni importanti sul giudizio storico relativo per esempio alla dittatura comunista, evitando addirittura di trattarla oppure offrendo una prospettiva parziale in merito al suo sviluppo e agli anni della massima espressione.
Non è raro, infatti, che i giovani prendano il diploma di scuola superiore senza sapere nulla del periodo tra il 1948 e il 1989, ossia quello della cortina di ferro e delle drammatiche condizioni di vita delle persone in Unione Sovietica o, in modo particolare, nei cosiddetti “Stati satellite” (Romania, Ungheria, Cecoslovacchia, Bulgaria e Polonia).
Lo studio delle vicende di questi paesi dovrebbe essere inserito – seppure in forma sintetica – in tutti i libri di storia, non essere relegato a una dimensione prevalentemente universitaria o a discrezione del docente di turno.
Una lettura illuminante quanto poco conosciuta a tal riguardo è quella della monografia sull’Europa del dopoguerra realizzata dallo studioso Tony Judt: si tratta della maestosa opera intitolata appunto “Dopoguerra”, periodo che l’autore ricostruisce attraverso un’esauriente quanto impressionante analisi dei principali avvenimenti nelle due “Europe”, quella orientale e quella occidentale.
Su quest’ultima un’ampia trattazione è dedicata al ’68, ossia al fenomeno socio-culturale borghese le cui idee di rottura rispetto al passato (specie nell’ambito della sessualità) sono note e condivise tutt’oggi.
Le teorie che ne sono scaturite – conosciute come “sessantottine” – vengono analizzate in modo lucido e disincantato, dimostrando quanto anche questo tema dovrebbe essere oggetto di una trattazione approfondita e obiettiva sui tanti libri di storia.
Nella maggior parte di questi, difatti, non sono minimamente riportate le conseguenze legate alla dimensione umana che ha contraddistinto quel periodo, capace di travolgere un’intera generazione portando molti giovani alla deriva sociale nell’euforia di aver conquistato una (illusoria) libertà illimitata.
Nell’epoca delle fake-news, delle notizie parziali o manipolate da un’informazione discutibile perché politicizzata, la Storia può e deve tornare ad essere “magistra vitae”, così da garantire almeno ai giovani di domani un cruciale strumento in più: la capacità di orientarsi nella vita e in un mondo sempre più pericoloso nel suo essere caotico.
I
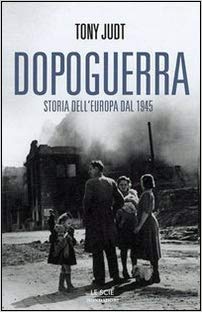 .
.
Sopra: la copertina dell’opera di Tony Judt.
Tag: storia, obiettività, condizionamenti ideologici, libri di storia, giudizi storici, scuole italiane.
Giulia Dettori Monna
